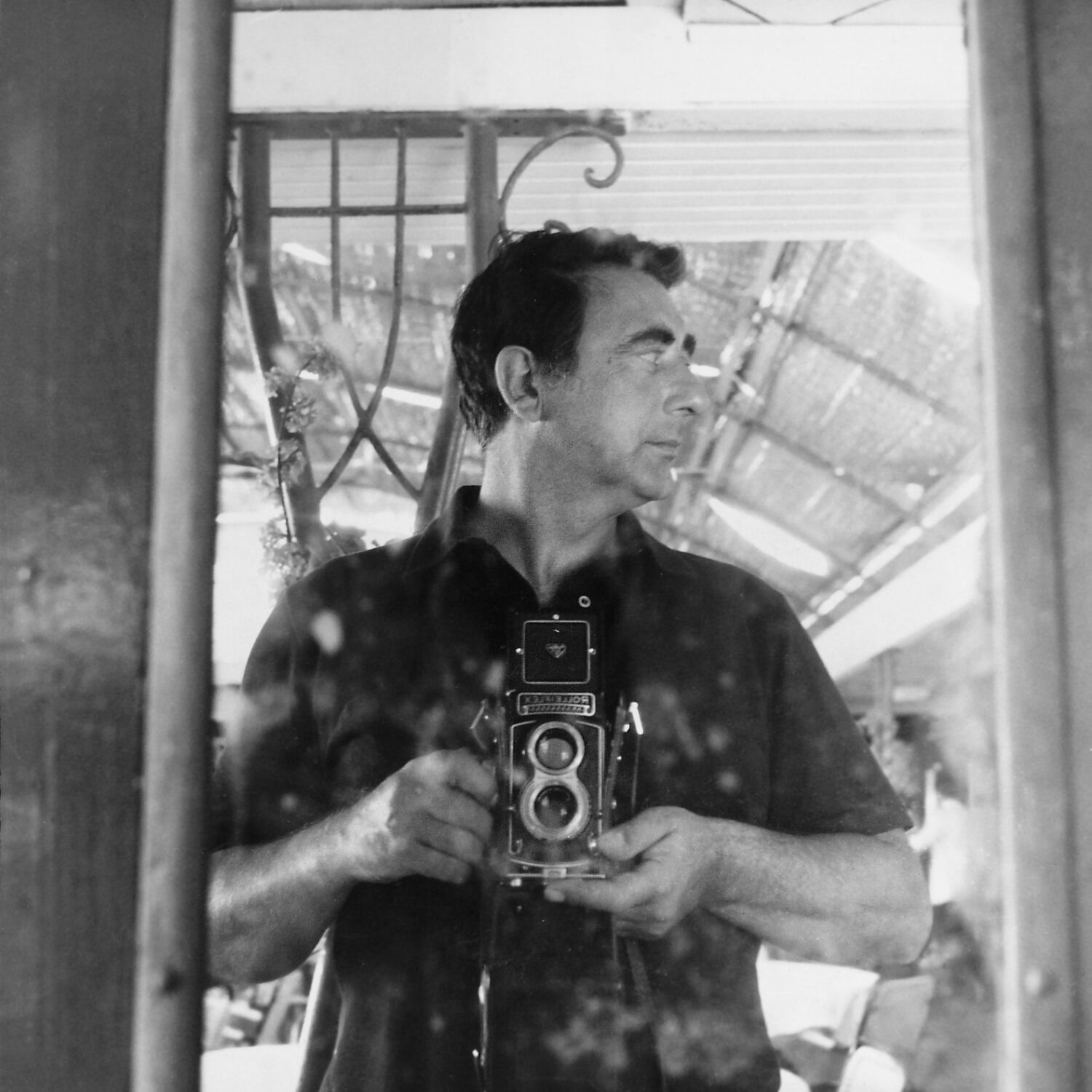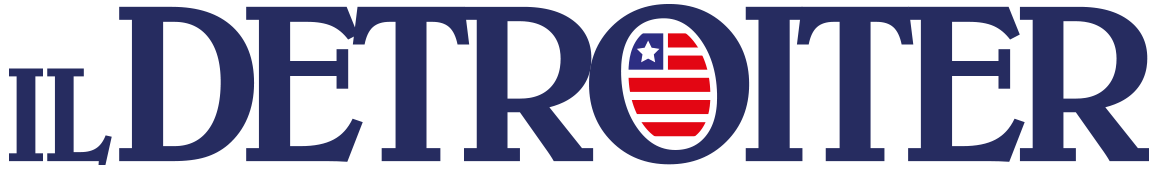Essere genitori oggi è una sfida complessa e spesso disorientante. In una società sempre più frenetica, performativa e dominata dal culto del successo, la genitorialità rischia di diventare un terreno di continue contraddizioni: da una parte la volontà di proteggere i figli, guidarli e garantirne il futuro; dall’altra, la necessità di riconoscerli come individui con diritti e bisogni propri. È in questo scenario che si inserisce un interessante articolo di Niccolò De Rosa, pubblicato su Fanpage.it, intitolato “I figli delle mamme tigri ottengono ottimi voti ma sono meno bravi nelle relazioni e nel gestire le emozioni”. L’analisi proposta offre molti spunti di riflessione per chi, come me, si occupa di studiare come è cambiata – e sta cambiando – la genitorialità, in un’epoca in cui i vecchi modelli educativi si scontrano con nuove esigenze e sensibilità.
Il focus dell’articolo ruota attorno a uno stile educativo tanto noto quanto controverso, quello delle cosiddette “mamme tigri”, ovvero “quel genitore – che nelle società asiatiche viene spesso identificato con la madre – esigente e severo, che punta tutto sul successo accademico dei figli, anche a costo della loro felicità”.
Come sottolinea De Rosa, “il termine ‘mamma tigre’ è diventato famoso grazie al libro di Amy Chua del 2011, Battle Hymn of the Tiger Mother. Si riferisce a uno stile genitoriale severo, caratterizzato da disciplina ferrea, aspettative altissime e orari di studio rigorosi, con poco spazio per il gioco e il relax”. Un modello che, se da un lato mira a sviluppare nei figli determinazione e senso del dovere, dall’altro può compromettere la loro serenità e capacità relazionale.
Uno studio recente guidato dalla ricercatrice Chengkui Liu, riportato nell’articolo, ha esaminato gli effetti di questo approccio: “Il team ha così scoperto che circa il 49% delle madri intervistate dichiarava di rivendicare l’autorità finale sull’istruzione dei figli. I dati, pubblicati su Economics and Human Biology, hanno poi mostrato che i figli di queste madri tendevano a ottenere risultati migliori nei test di abilità cognitive – come la memoria di parole o la matematica – ma punteggi più bassi sugli indicatori di abilità non cognitive, legati ai tratti della personalità come coscienziosità, apertura o stabilità emotiva”.
Il tempo familiare, evidenzia la ricerca, è fortemente sbilanciato a favore dello studio, a discapito di esperienze affettive e sociali: “Le madri che hanno il controllo delle scelte educative tendono a dedicare più ore alla supervisione dei compiti, alla cura quotidiana e all’acquisto di risorse educative, come corsi extra o materiali di studio. In cambio, però, si riduce drasticamente il tempo dedicato ad attività ricreative o sociali”.
Il quadro che emerge, pur offrendo risultati scolastici soddisfacenti, presenta limiti importanti per quanto riguarda la formazione del carattere e dell’armonia emotiva: “Non si osserva, invece, un aumento dell’attenzione verso attività che favoriscono lo sviluppo emotivo, la creatività, la ricerca di nuove amicizie o il legame genitore-figlio”.
Il ruolo dei genitori si è profondamente trasformato. La figura autoritaria del passato ha lasciato il posto a una genitorialità spesso incerta, che oscilla tra iperprotezione e permissivismo. In molti casi, i genitori cercano di colmare la perdita di autorevolezza con comportamenti poco funzionali: il voler essere “amici” dei figli o l’adozione di modelli educativi troppo rigidi. In realtà, il compito educativo richiede fermezza, ma anche empatia, ascolto e capacità di trasmettere valori. Un genitore che si pone come “adultescente”, che si confonde con il gruppo dei pari, rischia di disorientare ulteriormente figli alla ricerca di punti di riferimento solidi.
Le mie ricerche su preadolescenti e famiglie mostrano un aumento della fragilità emotiva nei ragazzi, spesso privi di una guida autorevole, ma rassicurante. La società ha superato il modello educativo tradizionale, e con esso sono cambiati linguaggi, codici e strumenti. I genitori non possono affrontare da soli queste sfide: serve una rete educativa diffusa, un’alleanza concreta tra scuola e famiglia.
Nonostante le difficoltà, educare bene è ancora possibile. Serve consapevolezza, formazione e supporto. Per questo continuo a promuovere la necessità di una “Scuola per Genitori”, un percorso condiviso con esperti per imparare a conoscere i nuovi bisogni dei ragazzi e accompagnarli con coerenza, senza rinunciare al ruolo educativo. È solo attraverso l’ascolto, il confronto e la responsabilità che si può tornare a essere figure significative nella crescita dei propri figli.
Il modello delle “mamme tigri” funziona sul piano delle performance, ma lascia scoperti molti degli aspetti che rendono un individuo equilibrato e capace di affrontare il mondo. Un genitore consapevole sa accompagnare con fermezza, amare con equilibrio e sostenere la crescita dei figli con fiducia. E oggi, in un tempo in cui le relazioni sono più complesse e i giovani più vulnerabili, il vero compito educativo è proprio quello di ritrovare un orientamento sicuro.
L’articolo Papà e mamma tra autorità e affetto: l’equilibrio difficile della genitorialità contemporanea proviene da IlNewyorkese.