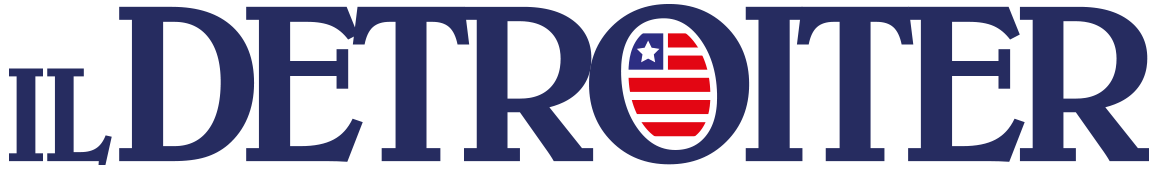Professoressa associata di Politica Economica al Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli, Mita Marra si sta impegnando con serietà e instancabilmente per costruire un ponte sempre più solido tra le istituzioni accademiche e il mondo dell’imprenditoria, specie al Sud.
Con la Summer School organizzata in collaborazione con Cornell Tech e con il sostegno dell’Ambasciata USA in Italia, ha portato un gruppo di ricercatori italiani a contatto con l’ecosistema economico newyorkese e l’imprenditoria italo-americana, per potenziare competenze trasversali e sviluppare una mentalità orientata all’innovazione tecnologica e sociale nei partecipanti. Con un preciso e ambizioso obiettivo in mente: dare al Mezzogiorno gli strumenti e il capitale umano necessari a vincere le sfide complesse di oggi e del domani. Ne abbiamo parlato diffusamente con lei, mentre è al lavoro già per una seconda edizione prevista per l’autunno 2024.
Si è appena conclusa qui a New York la Summer School “Bridging the Atlantic Pathways to Innovation and Entrepreneurship”, un percorso di formazione teso a rafforzare la collaborazione tra il mondo della ricerca e le piccole e medie imprese del territorio campano. Come nasce questo progetto?
Nasce da una ricerca e da una discussione sulle politiche di innovazione universitaria, che abbiamo sviluppato già l’anno scorso qui a Cornell Tech con un meeting di esperti, in collaborazione tra OCSE , Cornell Tech e Federico II, per capire come a livello internazionale, specialmente in Nord America e Nord Europa, le università promuovono gli ecosistemi imprenditoriali. In realtà, nasce ancora prima da uno studio sull’offerta formativa messo a punto dall’Università Federico II e che ha dato vita a un’offerta didattica versata nel digitale insieme alle big tech – Apple, Cisco, Deloitte – ma anche in campo industriale, in collaborazione con Leonardo, Ferrovie dello Stato, KPMG e altre multinazionali che si sono aggregate lungo il percorso. Ho direttamente studiato la logica e i primi risultati delle academy evidenziando come l’interazione dell’istituzione accademica con le imprese multinazionali abbiano dato vita a una diversa relazione tra l’università, il suo territorio e il mondo delle imprese. Il problema è capire come facilitare il trasferimento delle conoscenze tecniche e tecnologiche nel campo d’azione delle piccole e medie imprese, che ancora non sono all’altezza della trasformazione digitale, tecnologica e anche green che adesso stiamo attraversando. Proprio per facilitare questa trasformazione, questo upgrading, siamo arrivati all’idea di collegare il mondo della ricerca e quello delle imprese, attraverso un progetto di didattica vero e proprio, grazie al finanziamento dell’Ambasciata americana di Roma. Nel 2023, infatti, il progetto è stato selezionato per un finanziamento di 50mila dollari e il fondo in questione ha permesso di creare un percorso formativo teso a collegare ricercatori e imprese in quattro settori; aerospazio, elettronica, agroalimentare, arte, cultura e turismo nei territori della Campania. Abbiamo selezionato dieci ricercatori emergenti tra dottorandi in ingegneria industriale e scienze chimiche, studenti magistrali di innovazione sociale e startupper che hanno presentato i propri progetti di ricerca e hanno interagito con una serie di esperti e più di sessanta imprenditori. Siamo andati in cerca di imprenditori che operano direttamente in aree difficili, in contesti avversi, eppure in molti casi abbiamo scoperto delle eccellenze. Abbiamo realizzato quattro laboratori sui temi degli ecosistemi imprenditoriali g-locali, della ricerca e innovazione responsabile, della transizione alla sostenibilità e della valorizzazione dell’eredità culturale. Il percorso formativo itinerante ha mosso i primi passi a fine gennaio dall’area periferica ad Est di Napoli presso il Polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio, per proseguire alla volta di Cava de’ Tirreni, verso Altavilla Irpina per raggiungere Caggiano nel Vallo del Diano prima di approdare a New York a fine giugno. L’obiettivo è stato sempre favorire l’ascolto delle esigenze degli operatori del territorio da parte dell’università e creare reti di collegamento tra gli ecosistemi imprenditoriali locali e l’ecosistema più avanzato di New York.
Quello italiano e quello americano sono sistemi molto diversi. Che valore assume l’educazione universitaria qui in America e cosa possiamo e imparare dal loro mondo accademico?
La formazione italiana è sempre stata molto valida sul piano dei contenuti, delle conoscenze di base, delle conoscenze teoriche. Siamo molto forti su quel piano, tant’è che i nostri ricercatori sono apprezzatissimi a livello internazionale. Io stessa, dopo aver completato il percorso di laurea in Italia, ho potuto constatare, nel seguire altri programmi di formazione post-universitaria, come cambia l’approccio italiano da quello statunitense. Quello che a noi manca ancora è innanzitutto una capacità di applicare le teorie che studiamo ed elaboriamo a contesti concreti, come i contesti d’impresa per esempio. Ma il discorso si estende anche a tutto ciò che è il policy making delle istituzioni – vale a dire la capacità di sviluppare una visione con politiche e investimenti di lungo periodo che richiedono una comprensione olistica dei problemi e un’impostazione di ampio respiro, non solo di natura tecnica o tecnologica. Molto spesso i nostri studenti si trovano disorientati sguarniti nella transizione dal mondo della formazione universitaria al mondo del lavoro che richiede loro di interpretare situazioni complesse e sperimentare nuove soluzioni in condizioni di incertezza. In particolare, ciò è evidente nella relazione tra ricercatori e imprese. Un altro studio che ho recentemente condotto mostra che le imprese, specialmente in Campania, si rivolgono a consulenti o intermediari piuttosto che a centri di ricerca per acquisire conoscenze che non sono ancora disponibili al loro interno. L’università è presente ma non è preminente come in Nord America. Da qui nasce il progetto Percosi di Innovazione e Imprenditorialità / Pathways to Innovation and Entrepreneurship. L’idea che ci guida è proprio quella di sviluppare un’educazione imprenditoriale o meglio un’educazione all’imprenditorialità, che sia finalizzata non tanto e unicamente alla creazione di nuove imprese.
L’Università non deve quindi essere solo un incubatore di start-up…
Non tutti i nostri studenti devono diventare degli startupper, ma acquisire quello che si dice il mindset: una mentalità aperta ad ascoltare i problemi, a esplorarli nella multidimensionalità e complessità che spesso presentano, per capire che tipo di bisogni si devono soddisfare anche con un progetto di ricerca che ha l’ambizione di generare impatto sociale. Ciò è importante specialmente all’interno dei nostri dottorati che non prevedono ancora questo tipo di formazione in maniera sistematica e trasversale su tutti gli ambiti disciplinari. A livello di corsi di laurea magistrale abbiamo sicuramente migliorato l’interazione con gli stakeholder. Per esempio, io insegno in un corso di innovazione sociale e abbiamo collaborazioni attive con tanti attori del territorio. È importante infatti sottolineare che l’ascolto e l’interazione con le imprese e le organizzazioni non profit, richiede un lavoro continuo, incessante, paziente di ascolto e di condivisione. L’obiettivo non è semplicemente e pedissequamente soddisfare i loro bisogni, ma anche co-creare. Il nocciolo della questione sta qui, nella co-creazione di nuova conoscenza.
Come state rafforzando i rapporti con gli States in quest’ottica?
Proprio su questa scia, l’Università Federico II ha deciso di dotarsi di una sede qui a New York tra qualche mese. C’è già da vari anni in realtà, ma è condivisa con altre due università – Università Sapienza di Roma e Università di Bologna – fatto che rende necessario il coordinamento tra le istituzioni per allestirla e renderla fruibile. Il che non è facilissimo. Inoltre, il Covid ha rallentato i processi e anche la mobilità internazionale, per cui il primo evento che Federico II ha realizzato in questa sede di Cornell Tech è stato quello dell’anno scorso che abbiamo organizzato con gli altri esperti sul tema degli ecosistemi imprenditoriali e del ruolo delle università. L’obiettivo ora è sicuramente quello di sviluppare una relazione sistematica con Cornell Tech, tant’è che in programma c’è un nuovo evento a ottobre che coinvolgerà anche altri colleghi dell’Ateneo.
Parliamo della Campania, territorio ricco di piccole e medie imprese che si rafforzano sempre di più, che crescono e rappresentano una parte rilevante del tessuto economico e sociale dell’Italia. Cosa hanno portato di diverso gli imprenditori campani in un’esperienza del genere e quale valore può restituire questa esperienza agli imprenditori campani? Perché proprio la Campania e perché la commissione?
Siamo stati in Campania a esplorare i territori perché il progetto era proprio votato all’esplorazione di aree direttamente collegate al nostro bacino di utenza. Specie quelle che sono state classificate come aree interne, non sufficientemente servite e ascoltate. Stiamo parlando di aree che sono oggetto di una specifica politica di sviluppo territoriale in Italia, perché fortemente impattate da fenomeni come spopolamento e cambiamento climatico. Criticità, queste, che possono mettere a repentaglio anche le eccellenze imprenditoriali che esistono sul territorio con fenomeni e crisi ancora forse a uno stadio embrionale, che noi dovremmo però tempestivamente affrontare. Sul territorio, abbiamo esaminato problemi come la carenza di personale qualificato, lo spopolamento e gli effetti del cambiamento climatico sulle produzioni agroalimentari, ma abbiamo anche e soprattutto scoperto le molteplici risorse naturali, produttive e culturali ancora poco sfruttate che possono attrarre nuovi residenti e visitatori se collegate con realtà produttive e socioeconomiche più dinamiche.
New York può essere una risposta?
New York può essere una risposta nella misura in cui si va a sfruttare la velocità con cui il network si attiva come un modo per trovare soluzioni da sperimentare. E noi abbiamo fatto proprio questo – , tessendo incessantemente e pazientemente una rete di contatti tra gli ecosistemi produttivi locali per collegarli alla realtà newyorkese più dinamica e produttiva al fine di superare l’isolamento delle aree interne e accelerare l’innovazione. Ad esempio, abbiamo incontrato i produttori di vino nell’ambito del consorzio di tutela dei vini di Irpinia: lamentavano e lamentano tuttora condizioni economiche critiche, specialmente per la remunerazione degli agricoltori, ma anche una carenza di capitale umano, di personale da coinvolgere nelle produzioni viti-vinicole. Prezzi bassi che ancora possono crescere, contesti, villaggi, borghi bellissimi che sempre più si spopolano. Questo caso è diventato il project work su cui i partecipanti della summer school si sono cimentati — un gruppo che oltre ai nostri ricercatori emergenti ha incluso anche professionisti nel campo dell’innovazione, dello sviluppo locale e della cultura. Che cosa abbiamo fatto? Qual è stato il nostro valore aggiunto con il gruppo di ricercatori e esperti coinvolti? Abbiamo provato a utilizzare le tecnologie non soltanto fini a se stesse, ma per affrontare i problemi sociali più recalcitranti, partendo dal contesto in cui il problema si inserisce. Ripeto, qui in ballo ci sono delle sfide formidabili: il cambiamento climatico, la trasformazione digitale, ecc. e il progetto è solo agli inizi di un percorso di trasformazione cui intendiamo contribuire nel tempo.
Come si affronta tutta questa complessità?
Occorre mettere a punto soluzioni integrate in grado non soltanto di risolvere delle criticità sul piano della produzione, ma anche sul piano sociale ed economico. Questo approccio integrato per me è cruciale e viene molto spesso sottovalutato. Ad esempio, tutti i fenomeni di infusione di tecnologia nelle industrie tradizionali che noi stessi abbiamo osservato, molto spesso tralasciano quelle che sono le conseguenti trasformazioni sociali. Non guardano alla cultura che cambia e che deve cambiare per acquisire tecnologia, padroneggiarla e diffonderla. Non è semplicemente un’iniezione di tecnologia ciò di cui abbiamo bisogno, ma un cambiamento culturale molto più profondo e a diversi livelli, per cui l’aspetto sociale ed economico – si pensi ad esempio alla comprensione di come cambiano le relazioni tra imprese e comunità locali – sono questioni cruciali. Altrimenti le tecnologie rischiano di fallire, non andando ad incidere sulle cause dei problemi del ritardo di sviluppo. Perché, quando si infonde tecnologia, molto spesso si crea anche un capitale umano particolarmente sofisticato che può essere poi risucchiato in contesti e mercati del lavoro più competitivi e remunerativi. Quindi paradossalmente, più si forma il capitale umano, più si trasferisce tecnologia, e più si rischia che in quelle aree che non sono all’interno dei circuiti dinamici e delle agglomerazioni produttive, quel capitale umano venga perso. Dando così vita ad investimenti senza il ritorno atteso.
Ci sembra comunque l’esperienza newyorkese di questo progetto, concluso da pochissimo, sia andata bene, quali sono allora i progetti futuri?
L’esperienza è andata molto bene, al di là delle aspettative! Adesso occorre un po’ di riflessione su quanto è stato fatto, perché la discussione e l’engagement sono stati veramente molto – mi verrebbe da dire – vibranti. Quindi ci sono potenziali soluzioni a più livelli, a partire dal piano della progettualità locale. Che cosa facciamo adesso con il progetto di riqualificazione dei borghi e dei vini? Ma anche quali riflessioni tiriamo fuori da questa esperienza di formazione non tradizionale per riproporla in futuro? Su questo fronte, secondo me, bisogna fare tesoro di alcune delle questioni che sono emerse nell’interazione con l’ecosistema di New York, con la rete delle imprese e dei ricercatori italiani che abbiamo incontrato sia in Italia che negli States da coinvolgere nell’edizione numero due; come poi interagire con imprese anche in altri settori, non soltanto nell’agri-food, ma anche in campi a più alta intensità di tecnologia. Per quanto riguarda le relazioni con l’università americana, abbiamo avuto il piacere di accogliere diversi colleghi, con cui la cooperazione è di lunga durata. Però vogliamo capire anche che tipo di relazioni istituzionali si possono sviluppare tra Federico II e la rete delle università americane che con il progetto abbiamo contribuito a costruire.
A un’ottima seconda edizione, quindi!
L’articolo Mita Marra: l’Università di Napoli chiama New York proviene da IlNewyorkese.