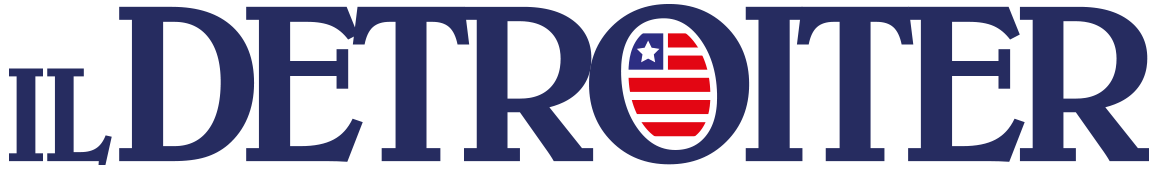La Dottoressa Fabiana Gregucci è una ricercatrice universitaria e direttrice amministrativa italiana specializzata in oncologia. Attualmente in carica presso il Weill Cornell Medicine di New York, la Dottoressa, in questa intervista, ci racconta come il suo “sogno americano” sia iniziato molto prima di arrivare fisicamente negli Stati Uniti. Fin da piccola, l’amore per lo studio e la lettura l’ha spinta verso le scienze umane e biologiche. Oggi, negli Stati Uniti, continua a crescere professionalmente, apprezzando le differenze culturali e le opportunità offerte dal sistema americano.
Dottoressa Gregucci, come è iniziato il suo “sogno americano”?
Questa domanda mi fa sorridere, e mi porterebbe a rispondere con un’altra domanda: cos’è il “sogno americano”? Per me il sogno americano è uno stato mentale, prima di essere un luogo fisico. È l’insieme di successi (poco rilevanti) e delusioni (fortemente motivanti per fare di più o fare meglio). È un’emozione fortissima al centro di mille pensieri. È consapevolezza, determinazione, liberazione, affermazione, impegno, resilienza, audacia, amore per la vita, curiosità per il non noto, voglia di crescere e di scoprire/scoprirsi oltre il limite (perché credo che di crescere e imparare non si finisca mai). In questa prospettiva, il mio sogno americano inizia da piccolissima, come studente alle prese con i primi anni scolastici che mi hanno da subito regalato l’amore per lo studio, la lettura, il sapere, in senso lato. Tantissimi perché e pochissime risposte, perlopiù incomplete e superficiali. Nel tempo è poi cresciuta la mia immensa passione per le scienze umane e biologiche e mi sono ritrovata rapita nel mondo delle biografie dei grandi scienziati italiani che sono stati una fonte incommensurabile di ispirazione. Ricordo perfettamente quando a 11 anni ho letto per la prima volta “Elogio dell’imperfezione” di Rita Levi-Montalcini. Un colpo di fulmine che è diventato l’amore della mia vita. Sicuramente non ero abbastanza matura per comprenderlo pienamente, ma ero abbastanza sognatrice e determinata per credere che ogniuno di noi ha uno scopo nella vita, che non si riassume nell’obiettivo ma si concretizza nel percorso durante il quale le difficoltà, le paure e gli errori sono opportunità per porsi domande ed immaginare soluzioni, provare e riprovare. Così è nato il mio “sogno americano”, molto prima di arrivare fisicamente negli Stati Uniti, ed in particolare a NY. Il mio “sogno americano” è l’amore autentico per la ricerca, è la promessa che rinnovo ogni giorno con me stessa di perseverare, perseguire e mantenere vivi quelli che sono i miei ideali di conoscenza e crescita, personale e professionale.
Cosa l’ha spinta a intraprendere la carriera di medicina e di specializzarsi nel campo dell’oncologia?
Nulla e nessuno. Non si è mai trattato di una spinta nell’intraprendere la carriera di medico prima e di oncologo dopo, nel percorso di formazione specialistica. Bensì è stato un crescendo di consapevolezza che la mia innata passione era ed è tuttora lo studio della medicina, intesa come scienza che studia la natura dell’essere umano e i processi fisiologici e patologici della vita, nella sua meravigliosa complessità. Non potrei immaginare di essere diversa da come sono, non penso mai alla mia professione come un lavoro o una carriera, ma ad una parte essenziale del mio essere. Il mondo dell’oncologia ed in particolare dell’oncologia radioterapica mi ha dato la possibilità di unire le mie passioni e i miei interessi trasversali per la medicina, le scienze biologiche e le scienze tecnologiche. Spesso mi imbatto bruscamente con lo stereotipo del medico inteso come “professionista che guarisce il malato”. Si può guarire o non guarire una malattia, che è comunque un processo naturale della vita e dell’evoluzione dell’essere umano su questo pianeta. Ma quello che sicuramente si può fare è avere cura della persona, evitandone l’identificazione attraverso la sua malattia. Il mio essere “physician-scientist” (purtroppo non abbiamo in italiano una traduzione efficace) si esprime nel mettere a disposizione del prossimo le conoscenze che ho acquisito e sviluppato nel mio percorso di studi e che continuo ad arricchire, e allo stesso tempo di dedicare il mio tempo ed impegno nel cercare di produrre e diffondere conoscenza.
Quali differenze culturali e lavorative ha notato tra i due paesi, specialmente nel campo della ricerca e della pratica medica?
Questa è una domanda molto complessa che dal mio punto di vista non ha una risposta. Sicuramente Italia e Stati Uniti hanno differenze culturali e lavorative profondissime, senza note di merito e demerito. Sono dei sistemi talmente diversi da non essere paragonabili, ancor di più nella sfera della ricerca e dell’assistenza medica. Spesso discuto con colleghi italiani che banalmente tagliano corto sulla diversificazione del sistema sanitario statunitense con un banale “il sistema è privato, e dove ci sono risorse economiche private tutto funziona diversamente, peccato per chi la sanità privata non può permettersela”. Questo è un esempio di visione stereotipata del modello americano che deriva da una disinformazione e una conoscenza di seconda mano che spesso non corrisponde alla realtà. D’altra parte, devo dire che mi capita raramente di discutere con i miei colleghi statunitensi del sistema sanitario italiano. In generale, gli americani apprezzano molto la nostra cultura, la nostra preparazione, la nostra organizzazione, la nostra capacità multitasking e problem-solving, e piuttosto che spendere il loro tempo a parole, cercano un modo per farci restare, diventare parte della quotidianità made USA per arricchirne il bagaglio culturale. Del resto, chi è quello stolto che ha una grande risorsa in casa e se la lascia sfuggire o non fa di tutto per provare a trattenerla?
In America si investe molto nella ricerca scientifica, nella tecnologia – soprattutto in ambito medico – e nelle giovani menti. Da quando è arrivata in America ha notato differenze su questo, rispetto all’Italia?
Sulla base della mia esperienza, la principale differenza che ho notato è la possibilità di fare carriera che il sistema organizzativo americano offre. Oltre alle competenze scientifiche specifiche, è importante sviluppare abilità trasversali come la gestione dei progetti, la scrittura scientifica e la comunicazione. Gli Stati Uniti valorizzano molto l’innovazione e l’imprenditorialità, quindi essere proattivi nel proporre nuove idee e progetti può portare a grandi opportunità di crescita.
Cosa le ha dato l’America in questi anni?
L’America mi ha dato e continua a darmi la possibilità di esprimere me stessa a 360 gradi in ambito professionale, non confinando le mie capacità e conoscenze alla routine assistenziale medico-paziente. Mi ha dato la possibilità di scoprirmi “scienziato” e di imparare molto di più di quello che mi aspettavo. Personalmente, mi dà la possibilità di mettermi in discussione ogni giorno, di confrontarmi con un mondo culturalmente e linguisticamente molto lontano da quello che conoscevo, dalla mia zona di confort. Ogni giorno affronto una nuova sfida, che sia banalmente discutere con il mio vicino per spiegargli che il panettone è un dolce tipico del Natale italiano e non una torta da mangiare tutto l’anno, a situazioni un po’ più complicate come la preoccupazione per mio figlio di nove anni troppo italiano per essere americano e troppo americano per essere italiano. L’America mi ha anche fatto capire l’importanza della cittadinanza, un diritto che spesso diamo per scontato e mi sta facendo appassionare di legislatura, di politica e di economia internazionale. In particolare, NY in questa avventura è una città eccezionale, un’esperienza senza paragoni. Una giungla metropolitana che vive di tempi, ritmi, regole, culture uniche al mondo, e che ha la capacità di travolgermi e di conquistarmi ad ogni angolo in ogni momento. Allo stesso tempo però l’America non mi ha solo dato, ma mi ha anche tolto alcune cose, soprattutto a livello affettivo. Mi ha portato via la vicinanza di alcune persone che ritenevo amiche, la tranquillità di poter visitare i miei familiari con frequenza e nei momenti di bisogno. Mi ha portato via l’illusione che la verità è unica e oggettiva e che la vita scorre lentamente. Mi ha portato via la perfetta gestione grammaticale e lessicale della mia lingua nativa. Ogni tanto penso “almeno prima una lingua la conoscevo bene, adesso ne conosco 2-3 (italiano, americano e un po’ di spagnolo), ma male o malissimo”. Insomma, storie di un’ordinaria expat, con le sue luci e ombre.
In passato è arrivata anche a vincere una borsa di studio per un progetto in Texas. Ci racconti questo passaggio.
I mesi che ho vissuto in Texas sono stati bellissimi, e ringrazio l’AIRO che è l’Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica per avermi conferito il premio che mi permesso di partire per questo viaggio. Non potrò mai dimenticare l’emozione del mio primo giorno all’MD Anderson Cancer Center. Mi ricordo che c’era un pulmino che veniva a prendermi da vicino casa (le distanze a Houston sono sovraumane e i trasporti pubblici scarsi) per portarmi al centro di ricerca con la scritta “cancer” barrata con una linea rossa, a rafforzare l’idea dello scopo della ricerca. In quell’occasione ho potuto approfondire lo studio della radioterapia stereotassica, su lesioni tumorali a livello polmonare, pancreatico ed epatico e lo studio della radiomica, un campo di ricerca che permette di guardare l’imaging radiologico non con la vista ma attraverso un’analisi matematica complessa che fornisce informazioni che l’occhio umano non potrebbe percepire. E poi era Houston, la città che ha portato l’uomo sulla Luna. Insomma, in questa parentesi ci sono stati tanti dettagli che l’hanno resa importante. Houston mi ha dato uno spaccato degli Stati Uniti diverso da NYC e non posso fare altro che apprezzare l’opportunità di aver conosciuto storie diverse dello stesso racconto.
Attualmente, invece, lavora come Ricercatore Universitario e Direttore Amministrativo al Weill Cornell Medicine di New York. Di cosa si occupa esattamente e qual è la sfida più importante del momento per lei?
Esattamente. In questo momento della mia carriera professionale ho il privilegio di poter dedicare tutta la mia completa attenzione alla ricerca clinica e traslazionale, nel Dipartimento di Radiation Oncology, sotto la guida della Prof. Silvia Formenti, ed ho la grande fortuna di collaborare con colleghi eccezionali, scienziati e medici di fama internazionale, provenienti da diverse parti del mondo. In particolare, mi occupo dello sviluppo di nuovi studi e protocolli di trattamento in ambito oncologico, così come della raccolta ed analisi dei dati di trials avviati in passato e che oggi sono abbastanza maturi da permetterci di ricavarne risultati che possono cambiare il corso dell’oncologia. Del resto, il motto di Weill Cornell Medicine è “We’re Changing Medicine”, e in queste poche ma incisive parole, si identifica perfettamente il mio impegno quotidiano e di tutti i professionisti che lavorano a Cornell. Professionalmente parlando, la sfida più importante che sto affrontando è scoprire me stessa sotto un profilo manageriale di altissimo livello, attraverso la leadership amministrativa di un cospicuo grant finanziato da NIH/NCI (National Institutes of Health/National Cancer Institute), denominato ROBIN. Questa opportunità unica mi permette di unire le mie skills e conoscenze in ambito medico, biologico e di ricerca, con l’altro risvolto della medaglia che riguarda la capacità di organizzare, dirigere, finalizzare tanti diversi tasks inerenti questo complesso progetto, non ultimo anche l’aspetto economico-finanziario, relativo alla gestione dei fondi.
Ci parli del progetto ROBIN.
Come accennato ROBIN, che è un acronimo che sta per “Radiation Oncology-Biology Integration Network”, è un esteso progetto di ricerca clinica-traslazionale, finanziato da NIH/NCI, che mette insieme numerosi e prestigiosi gruppi di lavoro, come Weill Cornell Medicine, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, University of Chicago, University of Maryland, Thomas Jefferson University, Cleveland Clinic Foundation, Emory University, Washington University, Harvard University, University of California San Francisco, con lo scopo di:
Supportare la ricerca per capire meglio come le radiazioni influenzano la funzionalità e la biologia delle cellule sane e delle cellule tumorali;
Raccogliere campioni biologici prima, durante e dopo il trattamento radiante da pazienti trattati con radioterapia;
Formare una squadra multidisciplinare di esperti e scienziati che abbiano competenze trasversali, coinvolgendo clinici, fisici, biologi, biotecnologi, genetisti, biochimici, statistici, bioinformatici, matematici, per migliorare gli studi clinici sulla radioterapia, utilizzando l’applicazione della scienza omica.
Cercando di dare una spiegazione più completa, dobbiamo considerare che circa il 50% dei pazienti oncologici viene trattato con radioterapia durante il suo percorso di cura. Da quando la radioterapia è stata introdotta come trattamento per il cancro oltre cento anni fa, i progressi e la ricerca si sono sempre più focalizzati sull’approccio tecnologico e sui calcoli matematici per ottimizzare il trattamento, trascurando un aspetto importantissimo che riguarda la biologia della cellula tumorale e delle cellule sane dell’organismo esposto alle radiazioni. Le scoperte recenti nella ricerca genomica umana, insieme alla disponibilità di grandi quantità di dati e nuovi strumenti molecolari usati per la medicina di precisione, non sono state ancora sfruttate a pieno nell’oncologia radioterapica. In questo contesto, ROBIN offre l’opportunità di applicare queste nuove conoscenze biologiche/genomiche/biochimiche/bioinformatiche/biostatistiche per aprire la conoscenza su questo mondo inesplorato e migliorare il trattamento radioterapico e la sua efficacia in combinazione con altri farmaci oncologici, non attraverso lo sviluppo di una tecnica/tecnologia ma attraverso lo sviluppo di una conoscenza su cosa accade e come funzionano le cellule quando esposte alle radiazioni.
Storicamente, la maggior parte della ricerca in radiobiologia è stata fatta su cellule in laboratorio o in modelli preclinici, con pochissimi dati raccolti da tumori umani veri e propri. Questo ha creato una situazione in cui la precisione tecnica della radioterapia è migliorata, ma la comprensione di come tumori e tessuti normali rispondono alle radiazioni nel tempo è rimasta indietro, soprattutto negli esseri umani, rispetto ad altre forme di terapia oncologica, creando un divario di conoscenza e un bisogno insoddisfatto di caratterizzare il trattamento radioterapico per migliorare il tumor cell killing e ridurre gli effetti collaterali sui tessuti sani. Ecco! ROBIN cerca di fare tutto questo e molto di più. Infatti, un’altra componente altrettanto importante del programma, non è solo quella di creare conoscenza, ma di far nascere professionisti che siano esperti di tale conoscenza e che possano diffonderla nel mondo. All’interno di ROBIN, in questo momento, collaborano più di 100 scienziati, suddivisi in 5 gruppi, denominati ImmunoRad, OligoMet, GenRad, KIDSROBIN e METEOR. Ci riuniamo, virtualmente, circa 5-6 volte al mese, ogni mese, ed una volta l’anno di persona, per discutere e condividere i vari risultati raggiunti, siano essi positivi o negativi, cercando di supportarci e aiutarci a vicenda per raggiungere uno scopo di conoscenza che va oltre la notorietà del singolo centro, mirando ad un bene comune per l’intera umanità. Tutto questo non sarebbe possibile senza il grande supporto da parte, scientifico ed economico, di NIH/NCI.
Ha dei consigli per altri giovani ricercatori ed aspiranti medici che vorrebbero realizzare il proprio sogno americano?
Potrebbe sembrare un consiglio banale, ma quello che posso suggerire è di non arrendersi mai, di credere sempre in sé stessi, di sognare in grande, di guardare all’obiettivo ma allo stesso tempo di gioire del percorso. Guardate alle difficoltà ed ai fallimenti come opportunità per immaginare e attuare soluzioni a cui non avevate pensato prima. Auguro ad ogniuno di trovare la propria America e di inseguirla incondizionatamente, ovunque essa sia e qualunque cosa significhi.
L’articolo La Dottoressa Fabiana Gregucci si racconta tra ricerca universitaria e medicina oncologica proviene da IlNewyorkese.