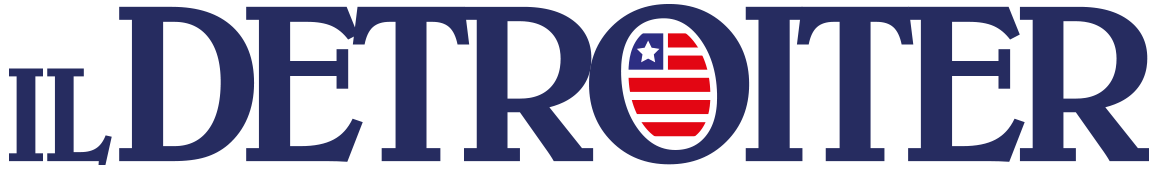Negli ultimi mesi la narrativa italiana ha messo in campo storie molto diverse tra loro, ma accomunate da un’urgenza emotiva forte: il bisogno di dare un nome al dolore, di misurarsi con ciò che ci cambia e di capire dove, davvero, sia la “casa”. Dai romanzi che intrecciano memoria e denuncia civile a quelli che esplorano fragilità e rinascita, queste uscite raccontano l’amore nelle sue forme più complesse: salvifico, ingannevole, mancato, ritrovato.
In questo articolo metto insieme cinque titoli che, ciascuno a modo suo, parlano di scelte irrevocabili e seconde possibilità: L’amore mio non muore di Roberto Saviano, Quel posto che chiami casa di Enrico Galiano, Tradita di Maria Carboni, Sirene di Laura Crema e I giorni in cui ho imparato ad amare di Francesco Sole. Un percorso di lettura scorrevole, tra thriller, romanzo di formazione e narrazioni più poetiche, per orientarsi tra le novità e scegliere da quale storia farsi prendere.
In L’amore mio non muore, Roberto Saviano sceglie una forma ibrida – romanzo e ricostruzione civile – per riportare alla luce la vicenda reale di Rossella Casini, giovane studentessa fiorentina che, inseguendo un amore assoluto, finisce intrappolata nella logica di potere e di paura della ’ndrangheta. Saviano racconta senza l’alibi della distanza: costruisce tensione, ma soprattutto prossimità emotiva, facendo sentire al lettore quanto sia sottile il confine tra slancio e cieca fiducia, tra desiderio di “salvare” e rischio di essere divorati da un mondo che non ammette eccezioni. Il risultato è una narrazione che non punta al colpo di scena, ma alla progressiva compressione dell’aria: si legge con il nodo in gola, perché ogni pagina sembra chiedere quanto può costare l’amore quando si scontra con un sistema che usa i sentimenti come leva e ricatto.
Il libro funziona anche per come mette a tema la memoria: non un’icona, ma una persona, con la sua energia e le sue contraddizioni, restituita attraverso un impianto che intreccia fatti, testimonianze e – dove i vuoti non si colmano – immaginazione responsabile. Lo stile è più accessibile rispetto alla scrittura “d’inchiesta” pura, ma non per questo meno politico: la lingua spinge sull’urgenza, sull’indignazione e sulla pietà, e a tratti può sembrare volutamente insistita nel martellare l’emozione (scelta che qualcuno potrebbe avvertire come eccesso). Però l’intento è chiaro: non lasciare al lettore la comodità di archiviare la storia come “cronaca”, bensì costringerlo a guardare il punto in cui affetto, dipendenza e violenza si intrecciano. È un libro duro e necessario, che resta addosso perché parla di mafia senza mitologie e di amore senza romanticismi: come di due forze capaci, ciascuna a suo modo, di pretendere tutto.
In Quel posto che chiami casa Enrico Galiano costruisce un romanzo intimo e insieme “narrativo” nel senso più caldo del termine: si entra subito nella testa (e nel cuore) di Vera, che da bambina convive con una voce persistente, quella del fratello Cè, morto quando lei aveva quattro anni—una presenza ironica, tagliente, a tratti consolatoria e a tratti inquisitoria, che la incalza con domande identitarie (“sei davvero Vera?”). Attorno a lei ruotano il peso di un modello impossibile (il “figlio perfetto” idealizzato), l’amicizia salvifica di Gin e una svolta quasi fiabesca, quando Vera—contro ogni prudenza—segue una coccinella oltre i cancelli di una clinica e incontra Francesco, figura-chiave che sembra conoscerla più di chiunque altro e che la avvicina a un segreto familiare rimasto sepolto. La trama procede come un filo teso tra realtà e percezione: non tanto “cosa succede”, quanto come Vera impara a decifrare ciò che le accade.
Il punto forte del libro è la capacità di parlare di fragilità senza etichette facili: la voce di Cè è insieme rifugio e gabbia, e Galiano la usa per raccontare lutto, perfezionismo e paura di non essere mai abbastanza, con una scrittura molto dialogata e piena di immagini-motto (a volte volutamente “da evidenziatore”). È un romanzo che tende la mano a chi si sente fuori posto, e che insiste sul coraggio di diventare sé stessi: la “casa” promessa dal titolo non è tanto un indirizzo, quanto un approdo interiore conquistato attraversando ciò che si è evitato per anni. Se in alcuni passaggi l’emozione può sembrare spinta fino al limite del melodramma, l’effetto complessivo resta potente proprio perché non giudica: accompagna. E quando chiude il cerchio, lo fa lasciando addosso quella sensazione rara dei libri riusciti—non di essere stati intrattenuti, ma riconosciuti.
In Tradita Maria Carboni firma un esordio che usa le regole del legal thriller per raccontare una caduta molto concreta, prima ancora che spettacolare. La protagonista è Pazienza Mantovani (“Paz”), avvocata romana, madre single, abituata a stare dalla parte dei più deboli ma costretta a fare i conti con bollette e precarietà: quando accetta un posto nello studio legale più potente della città, capisce subito che sotto la facciata di prestigio c’è un vuoto inquietante — la collega che sostituisce è morta da poco, in un presunto suicidio. Da lì la storia accelera tra ombre di corruzione e ricatti: un magistrato legato al passato di Paz viene ucciso e la donna finisce risucchiata in un meccanismo che la spinge fino al paradosso di dover “ammettere” colpe non sue.
Il romanzo funziona soprattutto quando trasforma l’indagine esterna in una domanda interna: giustizia o vendetta, dignità o sopravvivenza, e quanto costa restare fedeli a sé stessi quando il sistema ti chiede di piegarti. Carboni scrive con un ritmo da pagina-che-si-gira, ma cerca anche un impatto emotivo “da thriller dell’anima”: la tensione non nasce solo dai colpi di scena, bensì dal senso di accerchiamento e dalla ferita del tradimento (personale e istituzionale). Se a tratti l’enfasi su passione e dramma può sembrare spinta, l’arco di Paz — donna competente, vulnerabile, combattiva — resta il centro magnetico del libro. Nel complesso, Tradita è una lettura adrenalinica e amara, che intrattiene ma lascia anche una scia di domande scomode su potere, reputazione e verità
In Sirene di Laura Crema (Voglino Editrice, collana “Essere”), più che un romanzo in senso tradizionale ci si trova davanti a un libro breve e fortemente visivo (54 pagine) che usa la figura mitologica della sirena come metafora di una frattura interiore: metà donna e metà pesce, e dunque “dimezzata”. Le immagini mettono al centro il dolore come perdita e mancanza, ma soprattutto come punto di partenza di un percorso: il viaggio per rimarginare, ritrovarsi, rinnovarsi. L’idea più riuscita è quella delle “sirene mute”: creature che hanno deposto il canto, e proprio per questo spostano l’attenzione dalla seduzione alla resistenza, dalla voce al corpo, dal richiamo all’ascolto di ciò che resta in profondità.
Il libro convince quando lascia spazio al lettore: non spiega, suggerisce, e la sua forza sta nel modo in cui trasforma un mito celebre in una meditazione su integrità e libertà—quella “volontà di interezza” che spesso custodiamo così a fondo da non sentirla. Proprio questa natura allusiva, però, può spiazzare chi cerca una trama articolata o personaggi “da seguire”: qui l’arco narrativo è emotivo, affidato al montaggio delle immagini e al loro ritmo. Se ci si lascia prendere per mano, Sirene diventa un oggetto di lettura lento e ipnotico, un piccolo atlante di ferite e guarigioni, dove il silenzio non è assenza ma una forma di coraggio
In I giorni in cui ho imparato ad amare (Sperling & Kupfer, 2025), Francesco Sole affida la storia a Cesare Rinaldi, uno scrittore “in fuga” che da anni si è rifugiato a Milano, lontano dalle colline toscane in cui è nato e da tutto ciò che gli fa paura: responsabilità, sentimenti, radici. La telefonata della zia Ada lo costringe a tornare: il padre è morto e l’azienda vinicola di famiglia è sull’orlo del fallimento; tra polvere, mosto e vendemmia, Cesare si ritrova davanti ai silenzi e alle colpe di sempre, ma soprattutto ad Alessandra, la donna che ha amato e abbandonato. Nel mezzo, una psicologa incontrata quasi per caso diventa la “bussola” che lo spinge a rimettere mano alla propria musica interiore, fino al bivio più semplice e più terribile: scappare ancora o restare.
Il romanzo funziona quando usa il ritorno a casa come lente emotiva: non tanto per sorprendere, quanto per far sentire la fatica (e la dolcezza) di disimparare l’autosabotaggio. Il motivo della “frequenza del cuore” è un’idea efficace perché rende leggibile il cambiamento di Cesare senza trasformarlo in predica, e la cornice del vigneto – concreta, sensoriale – dà corpo a un percorso di guarigione che altrimenti rischierebbe di restare astratto. A tratti si avverte la tentazione del romanzo-messaggio (anche con l’ingresso esplicito dei “cinque linguaggi dell’amore”), e alcuni snodi sono volutamente “da romance” più che da realismo psicologico. Ma se si accetta questo patto, I giorni in cui ho imparato ad amare è una lettura calda e scorrevole: parla di seconde possibilità senza cinismo, e lascia addosso quella voglia – non banale – di smettere di fuggire dalle cose che contano.
Insieme, questi cinque libri disegnano una piccola mappa delle inquietudini (e dei desideri) contemporanei: la ricerca di verità, il bisogno di appartenenza, la fatica di restare integri quando tutto spinge a spezzarsi. Che si tratti di una storia civile che inchioda alle responsabilità collettive, di un ritorno a casa che riapre ferite antiche, di un thriller che mette alla prova la fiducia, o di un racconto più simbolico che parla per immagini, il filo comune è sempre lo stesso: nessuno si salva senza attraversare ciò che teme.
Se cercate una lettura che scuota e faccia riflettere, Saviano è la scelta più netta; se volete una storia di crescita emotiva e riconciliazione, Galiano e Sole accompagnano con calore; se preferite tensione e dinamiche di potere, Carboni tiene alta l’adrenalina; se invece vi attira una voce più poetica e breve, Crema lascia spazio al silenzio e all’immaginazione. Qualunque sia il vostro punto di partenza, sono romanzi che non chiedono solo di essere letti: chiedono di essere ascoltati.
L’articolo Idee regalo: la nuova narrativa italiana proviene da IlNewyorkese.